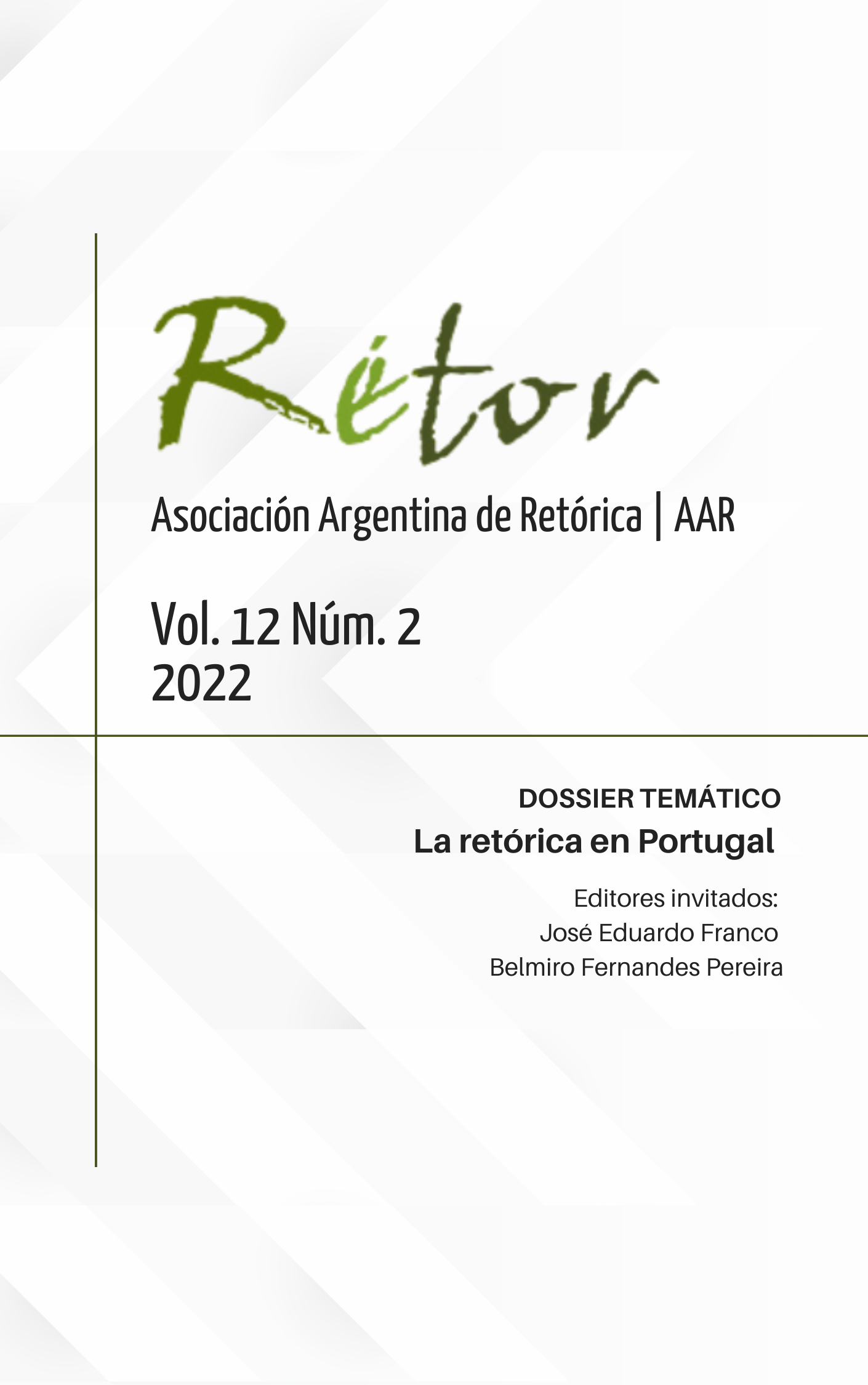Retorica e Antiretorica nell'Utopia di Tommaso Moro: dall'inventio letteraria alla conversione filosofica
Contenido principal del artículo
Resumen
L’Utopia di Tommaso Moro presenta numerose architetture retoriche che, per vie più o meno lineari, possono essere ricondotte ai modelli di retorica antica, in particolare a quelli di Aristotele, Cicerone e Quintiliano. In modo particolare, emerge in modo decisivo uno degli obiettivi fondamentali che guidavano l’antica retorica, la persuasione. Se al lettore non è presentato un trattato filosofico, ma una composizione che pretende, attraverso un racconto, di modificare alcune opinioni politiche e filosofiche, o di mettere in questione la legittimità di altre, questo avviene attraverso un’attenta ripresa di strumenti retorici e in particolare di quell’aspetto dell’antica ars retorica consistente nell’inventio. Entrambe le parti in cui il testo è suddiviso sono infatti del tutto tratte dalla fantasia dell’autore, per quanto questi abbia cura di legare la sua materia a contenuti verosimili di realtà. Proprio attraverso l’uso dell’inventio, l’Utopia sembra potersi inscrivere, in questo modo, nel modello protrettico antico, collocandolo nelle nuove condizioni dell’umanesimo del XVI secolo. L’uso strumentale della retorica sembra tuttavia contraddire il suo rifiuto programmatico da parte di Moro, giustificato dalla necessità di garantire un accesso alla verità che, proprio come accadeva nel modello platonico, deve espungere il più possibile figure che non siano quelle della filosofia. L’analisi del rapporto tra utopia e retorica ci consente, in questo modo, di avvicinare alcune delle contraddizioni storicamente rilevabili del genere utopico, quella tra uso della materia letteraria e fedeltà filosofica, quella tra concetto veritiero e sua trasmissione attraverso figure di pura invenzione, quella tra persuasione e conversione. Infine, tale analisi consente di comprendere il racconto utopico come una “formazione di compromesso” tra istanze represse e codici linguistici, rivelando in tal senso le forme con cui si determina l’obiettivo ultimo dell’Utopia: una conversione utopica.
Descargas
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Las obras se dan a conocer en la edición electrónica de la revista bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. Se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que i) se citen la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra); ii) no se utilicen para fines comerciales; y iii) se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.
Citas
Abensour, M. (2013). L’homme est un animal utopique. Utopique II. Paris: Sens & Tonka.
Aristotele. (2006). Retorica, in (a cura di M. Zanatta) Retorica e Poetica, . Torino: UTET, 139-442.
Canfora, L. (2014). La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone. Roma-Bari: Laterza.
Cicerone. (2019). Libri di retorica (detti Dell’invenzione). In (a cura di G. E. Manzoni) Opere di retorica (pp. 59-235). Brescia: Morcelliana.
Ferraro, G. (2019). Philosophical Conversion to Another Life. Epistrophè, Metanoia, Alethurgy and Philosophy as a Way of Living Otherwise”, Thomas Project, 2, 58-77,
Foucault, M. (2001). “Des espaces autres”, in Dits et écrits, II, 1976-1988, éd. ét. sous la dir. de D. Defert et F. Ewald. Paris: Gallimard, 1571-1581.
Macherey, P. (2011). De l’Utopie! Saint Vincent de Mercuze: De l’Incidence.
Mordacci, R. (2020). Ritorno a Utopia. Bari-Roma: Laterza.
Moro, T. (1961). Lettere della prigionia, tr. di M. T. Pintacuda Pieraccini. Torino: Boringhieri.
Moro, T. (1993); L’Utopia, o la migliore forma di repubblica, tr. di T. Fiore. Roma-Bari: Laterza.
Orlando, F. (1992). Per una teoria freudiana della letteratura. Torino. Einaudi.
Orlando, F. (2004). Saggio introduttivo, in S. Freud, Il motto di spirito, tr. it. di S. Daniele ed E. Sagittario. Torino: Boringhieri, 15-29.
Platone. (1997). Tutte le opere, a cura di E. V. Maltese. Roma: Newton e Compton.
Seneca. (2017). Opere morali, a cura di P. Ramondetti. Milano: BUR.
Spitzer, L. (1975). Critica stilistica e semantica storica, tr. it di A. Schiaffini. Roma-Bari: Laterza.